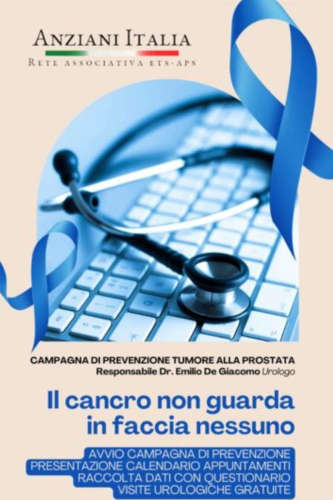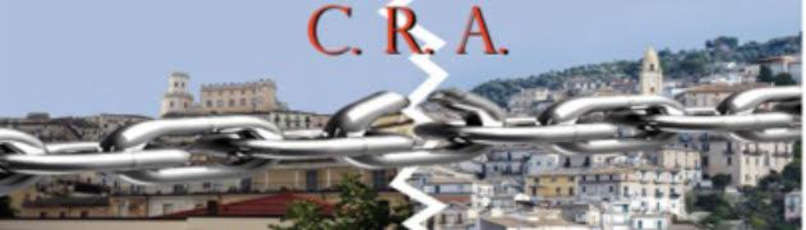“Una delle più sorprendenti ed utili invenzioni di questo scorcio di secolo è certo il telefono. Portare a distanze interminabili, per mezzo di corrente elettrica nei telegrafi, il movimento e riprodurre quindi in luoghi distanti da noi colla velocità del fulmine, per mezzo di puntini, una data figura che rappresenta le lettere dell’alfabeto, e comporre così le parole, ha del meraviglioso;
ma riprodurre colla stessa velocità la voce al naturale, mettere due persone nel caso di fare un discorso a cento chilometri di distanza, come lo farebbero a naso a naso, distinguendosi, senza potersi confondere con altre, la voce di chi parla, come si fa da vicino, rasenta l’incredibile”.
È quanto scriveva “Il Popolano” nel n. 15 del 6 agosto 1887. Un articolo di storia locale che è utile rileggere, dopo così tanto tempo, allorquando il telefono fisso è ormai quasi diventato un optional, sostituito velocemente da cellulari, social network e numerosi altri strumenti di comunicazione istantanea.
Il telefono, spiegavano i coriglianesi dell’epoca, ha un vantaggio sul telegrafo negli usi della vita pratica e nelle sue applicazioni; per usare il telegrafo, difatti, ci vuole un tirocinio discretamente lungo, e quindi non basta che uno avesse un ufficio telegrafico a sua disposizione per usarne, se non ha fatto un tirocinio di parecchi mesi e non ne ha appreso l’arte. Del telefono, invece, può usarne un savio ed un bambino, basta dirigere la voce a poca distanza al tubo della macchinetta, per trasmettere la parola alla sua destinazione, basta avvicinare il corno fatale all’orecchio per ricevere la risposta col suono naturale della voce di chi vi parla.
“In Italia – rilevava il giornale locale – si ha penuria di giovani, pratici a far da telegrafisti quando si vogliono impiantare uffici telegrafici nei piccoli Comuni; ma telefonisti sono tutti. Il telegrafo costa maggiori spese d’impianto e di manutenzione, il telefono relativamente offre una grande economia nell’uno e nell’altra. Per un 10 chilometri di distanza effettiva, la spesa sta tra le 600 alle 800 lire. Il telegrafo è per le comunicazioni tra Stato e Stato, tra grandi e grandi città, fra Emisfero ed Emisfero; ma per le comunicazioni nello interno della città, fra un piano ed un altro di un’officina, fra la casa ove si abita ed un negozio, uno stabilimento che ci appartiene, tra villaggio e villaggio, è più alla portata il telefono, anzi è il solo che può essere messo in uso”.
Ma chi fu il pioniere del telefono a Corigliano, il primo a portare tale novità? Il Barone Compagna, che così facendo mise in comunicazione il suo Casino di Palombella, “ove a 8 chilometri circa di distanza è andato ad estivare la famiglia, col Castello sito in questa città. Così qualunque sito delle nostre montagne può esser messo in diretta comunicazione con Parigi e Londra. Difatti un dispaccio da Londra, trasmesso a Corigliano e arrivato alla sua destinazione ai signori Compagna, può immediatamente dagli Agenti della Casa essere trasmesso a mezzo del telefono al Padrone di casa, che sta lontano ad estivare. Egli, stando in montagna, può tener conversazione con tutto Corigliano, come a casa propria”.
“Il Popolano” esortava quindi tutti i lettori a seguire l’esempio del Barone e la portata rivoluzionaria del telefono.
“Sia lode ai Barone Compagna che ha dato tra noi l’esempio dell’impianto di questo strumento di civiltà; sia lode al nostro Capo-Ufficio telegrafico, sig. Francesco Graziani, che ha così bene studiato il meccanismo da dirigere l’impianto del telefono del Barone, senza bisogno di chiamar da fuori macchinisti e specialisti che costano un occhio del capo. Si dirigano a lui i nostri villaggi che non hanno e che non possono aver telegrafo e vogliono mettersi in comunicazione col mondo civile. Così solo la nostra Provincia, disseminata e sminuzzata in centinaia di paeselli e borgate, può farsi una rete completa di comunicazioni, innestando la corrispondenza telefonica a quella telegrafica. Seguano l’esempio del Barone Compagna, tutti quei proprietari della Provincia che hanno necessità di corrispondenze frequenti con Stabilimenti e fabbriche loro lontane; la spesa non è tale che si debba essere Barone e Principe per sopportarla”.
Fabio Pistoia